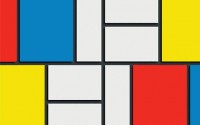“Viva arte viva” nel segno delle novità
Enzo Santese | grandi mostre | Il Ponte rosso N° 24 | maggio 2017
di Enzo Santese
L’apertura della Biennale di Venezia è sempre un’occasione ghiotta per fare il punto sugli esiti più recenti della ricerca contemporanea, partendo da un presupposto importante: l’arte di oggi non è tutta qui, ma, d’altro canto, la funzione della kermesse lagunare non è quella di una fiera campionaria dove con intento enciclopedico vengono immesse tutte le esperienze in atto al tempo d’oggi. Ogni edizione porta i segni di chi tecnicamente la dirige e quest’anno il compito è stato assegnato a Christine Macel, che nel suo ruolo di capo del Centro Pompidou a Parigi ha mostrato qualità di profonda conoscitrice di tutto ciò che si muove nel campo della creatività artistica internazionale. I risultati sono quindi in sintonia con chi ha dato all’evento la propria impronta di manager di assoluto valore. I numeri stanno a indicare un bello sforzo di rappresentare l’esistente nella sua veste più dinamica: non è un caso che il titolo della rassegna sia “Viva Arte Viva”, che può valere nella duplice funzione significante di interiezione entusiastica, ma anche la delimitazione a quelle forme che, pur talora derivate dalla tradizione storica, tendono a raggiungere i dati di novità in vari ambiti. Centoventi sono gli artisti, provenienti da cinquantuno paesi, senza contare poi quelli delle mostre collaterali, non sempre in linea (di qualità) con il resto, ma alcune di queste sono sicuramente di grande interesse per le opere e le azioni performative che contengono. E gli elementi che distinguono la rassegna di quest’anno da quelle precedenti sono davvero marcati, a cominciare dalla struttura espositiva stessa che oltre ai tradizionali padiglioni nazionali ne presenta altri nove definiti dalla curatrice “capitoli o famiglie d’artisti”: due ai Giardini, e sette dislocati tra l’Arsenale e il Giardino delle Vergini.
Una ricognizione completa sarebbe troppo lunga e poco consona a questo spazio; merita peraltro soffermarsi su alcune presenze e sugli effetti prodotti dalla mostra in termini di emozioni e reazioni.
Per l’Austria, due artisti dialogano tra loro non senza qualche stridore dal punto di vista visivo, eppure con sicura efficacia nell’impatto con il visitatore: da una parte c’è lo scultore Erwin Wurm, maestro del paradosso che aveva già fatto parlare di sé per la barca a vela piegata in due e collocata sul tetto di un albergo a Vienna; poi per aver piantato per terra un camion, come fosse un albero, a indicare che in tempo di migrazioni le merci e le idee viaggiano fino a raggiungere mete impensabili. Adesso presenta la Narrow House, la Casa Stretta, un edificio vero e proprio dalla funzionalità molto discutibile; in effetti, secondo un modulo che gli è congeniale, alterando completamente scala, proporzioni e volume, ha costruito una casa sulla falsariga di quella abitata da bambino, con l’altezza e la lunghezza reale, ma con la larghezza drammaticamente ridotta. Il tutto potrebbe essere interpretato come il frutto di una volontà burlona e comica, ma invece sottende una critica puntuta ai valori sociali che si incentrano nella fisicità dell’abitazione. L’altra artista del padiglione austriaco è Brigitte Kowanz che disegna lo spazio tridimensionale con le sue installazioni luminose, fatte anche per creare un cortocircuito tra realtà e illusione.
La Corea è presente con due personali di Cody Choi e Lee Wan che insieme, ognuno con i moduli della sua sensibilità, rimarcano il conflitto degli opposti, tradizione e modernità, consumismo e spiritualità, tendenza alla globalizzazione e desiderio di affermare la propria identità in un padiglione che è attraente nelle forme, problematico nel significato delle opere.
Xavier Veilhan, per la Francia, organizza il suo spazio come un luogo di registrazione, invitando all’esecuzione lungo i sei mesi della rassegna musicisti provenienti da diverse formazioni culturali e stili, dal jazz alle realizzazioni elettroniche; il mondo entra così in uno spazio nazionale celebrando l’idea dell’assoluta libertà del compositore, nel ricordo dei fatti di Parigi che hanno registrato vittime soprattutto tra i giovani del Bataclan, spettatori di un concerto rock. L’idea di un coinvolgimento interattivo sta anche nella poetica di Jordi Colomer, spagnolo, che propone un video nel quale gli spazi della città diventano palcoscenici di un teatro “inconsapevole” di mille cittadini. L’Australia è rappresentata da una delle sue artiste più conosciute all’estero e in Europa in particolare, la fotografa indigena Tracey Moffat, che dà vita al suo padiglione con due serie di fotografie e due video con una provocatoria attenzione a persone che stanno tra loro agli antipodi, evidenziando le emozioni di stelle del cinema e quelle di rifugiati che fuggono in barca.
In tempi di Brexit , non erano pochi coloro che attendevano qualcosa di strettamente legato alle questioni dell’Europa “più o meno unita”, invece la sorpresa è che il Padiglione britannico presenta l’opera di Phyllida Barlow, una scultrice che sa esprimere la massima energia plastica con materiali di assoluta leggerezza: collocando la propria poetica tra minimalismo americano e Arte Povera, la sua installazione, costituita da stoffe aggregate in grandi mazzi policromatici in sospensione, combina l’idea del monumentale con l’illusione di levità.
La sostanziale contiguità dello spazio russo con quello statunitense, quasi in un accenno di complementarietà tra l’uno e l’altro nell’ambito “felice” dell’arte contemporanea, sembra mettere in secondo piano su uno sfondo di opacità indistinta le immagini di Putin e Trump che si fronteggiano sullo scenario internazionale come su una semplice scacchiera: Grigory Bruskin è l’autore di “Scene Change”, una mega-installazione formata da oltre cento elementi in cartapesta con un video dove scorrono frasi relative a eventi del passato che, peraltro, funzionano da note didascaliche dell’opera stessa. Il californiano Mark Bradford invece, nel suo progetto “Domani è un altro giorno”, allinea una serie di lavori pittorici di bella efficacia per il brulicare di segni e tracce che richiamano l’idea di mappe ottenute da una prospettiva aerea.
Interessante sarebbe scoprire le ragioni per cui l’Iran dà spazio a un fuoriuscito, peraltro artista di sicura qualità: Bizhan Bassiri, iraniano di nascita naturalizzato italiano (a Palazzo Donà delle Rose). Evidentemente sono passati i tempi dell’integralismo religioso, sospinto fino al paradosso, e sono maturati i convincimenti che la real-politik suggerisce anche e soprattutto di essere con il meglio di sé sul campo degli eventi ad altissima valenza promozionale come la rassegna veneziana. È per questo che a Bassiri viene riservato uno spazio congruo alla sua mastodontica installazione, Tapesh: 24 metri lungo i quali sono dislocate 50 sculture, distinte tra 32 erme (rappresentanti l’uomo), 4 leggi (la possibilità della conoscenza e 14 bastoni (simbolo del pensiero che alimenta il sapere).
La Svizzera fa aleggiare nel suo padiglione la presenza di Alberto Giacometti (1901-1966), che per motivi imperscrutabili non espose mai nello spazio ufficiale elvetico, eppure nel 1956 le sue Femmes de Venise vennero ospitate in quello francese; tre artisti ipotizzano ognuno una ragione facendone motivo generatore di esperienza d’arte: Teresa Hubbard e Alexander Bircher inscenano i tratti salienti della vita di Flora Mayo, musa ispiratrice dell’artista, e Carol Bove “legge” i caratteri rivelatori delle sue sculture.
Dalla magia del Padiglione Italia all’utopia di “State in Time”
Il padiglione Italia con i suoi 1800 metri quadrati apre finalmente una finestra significativa sulla ricerca attuale nel nostro paese, grazie anche a un’avveduta opera della curatrice Cecilia Alemani che ha invitato nel suo spazio di manovra tre artisti di assoluto valore, Giorgio Andreotta Calò, Roberto Cuoghi, Adelita Husni-Bey, uniti nella comune tensione progettuale di un’interpretazione della magia, sull’onda di quanto l’etnologo e antropologo Ernesto de Martino (1908-1965) ha dibattuto nel saggio Il mondo magico. Potrebbe sembrare un disegno mirante a creare “l’isola che non c’è”, dove attutire le punte ispide della cronaca di oggi, invece è un modo per fermare l’attenzione dell’osservatore su aspetti della storia di oggi fissati in un’azione scenica performativa di grande richiamo interattivo per il visitatore. Giorgio Andreotta Calò, proprio riprendendo La fine del mondo di de Martino, propone il suo Senza titolo, una costruzione di tubi da ponteggio su cui una piattaforma di legno regge un mondo capovolto, con l’aggiunta di un gioco speculare in cui si rifletterebbero mondo degli inferi e mondo terrestre. Roberto Cuoghi, autore dell’ Imitazione di Cristo ispirato all’omonimo testo medioevale di dottrina cristiana e consistente in un tragitto, in mezzo a un buio con aree opalescenti, che tocca punti costellati da oggetti devozionali; Adelita Husni-Bey in The reading/La seduta manifesta il suo pensiero – con il video e la scultura – su problematiche di grande attualità come quelle della razze e del genere; e dalla materia dei tarocchi mutua e approfondisce alcuni aspetti della nozione di terra.
Indubbiamente i tre interventi nel padiglione Italia pulsano di una loro calda autonomia significante, riuscendo perfettamente a inserirsi nella tensione unitaria data dal tema.
Il Padiglione Venezia, curato da Stefano Zecchi, allinea le eccellenze dell’artigianato d’alto livello che hanno reso la città famosa in tutto il mondo; in questo ambito campeggia un esito d’arte indiscusso, quello di Marco Nereo Rotelli: infatti è autore di un’autentica stanza dove trasparenza e luce mettono in scena lo spazio della memoria in cui l’impalpabilità del sogno si coniuga con la fisicità del reale, data dalla speciale materia che consente l’illusione della liquidità dell’acqua, omaggio alla città lagunare risolta in forma poetica.
Per quanto riguarda i nove trans-padiglioni che nel nome stesso dato dalla Macel esprimono il senso dei loro contenuti, cioè spazi che superano l’angusto ambito nazionale e creano un’osmosi effervescente nei risultati di artisti provenienti da diverse origini e operanti in differenti condizioni di cultura e di stile; in questo modo, secondo il pensiero di chi l’ha concepito, per il fruitore è possibile fare un viaggio “dall’interiorità all’infinito” attraverso momenti di riflessione su concetti generali di gioia e paura, spazio comune, terra e tradizioni, sciamani e dionisiaco, tempo e infinito, fino allo spazio dei colori, dove il dato della spiritualità fa lievitare il mondo fisico degli oggetti in una sintesi multiforme fatta dal riverbero di tutte le precedenti stazioni.
Dal “Padiglione degli artisti e dei libri” a quello “del tempo e dell’infinito” si tende una trama narrativa densa di sollecitazioni a indagare sui ritmi organizzativi della società, sui suoi valori e sulle prospettive ipotizzabili.
Una delle caratteristiche essenziali di questa edizione della Biennale è di porre l’artista come protagonista assoluto dell’evento non solo nell’esibizione del proprio lavoro di ricerca, ma anche nella fornitura di un apparato didascalico approfondito sulle ragioni d’avvio, sulle dinamiche formative, sul rapporto tra idea progettuale e opera finita; proprio per questo i protagonisti della rassegna sono invitati a redigere e presentare documenti esplicativi del loro universo umano e poetico.
Una delle iniziative che sembra già raccogliere il favore di un vasto pubblico, sollecitato a “vivere” la Biennale veramente dall’interno è “Tavola aperta”: ogni venerdì e sabato uno degli artisti invitati alla Biennale consuma un pasto con i visitatori che prenoteranno il posto online; gli altri possono assistere al banchetto in streaming. È un modo per avviare una conoscenza più approfondita dei protagonisti dell’evento veneziano e delle loro fibrillazioni psicologiche.
In un tempo come questo in cui i confini si blindano, i muri si alzano e i passaporti regolari sono merce preziosa, c’è uno stato utopico che va in controtendenza; si tratta del Padiglione dello stato NSK (Iniziali del collettivo Neue Sloweniske Kunst) che ha concepito il NSK State in Time, una formazione statuale che non corrisponde a nessuno dei Paesi esistenti, ma vuole essere una realtà “sovrannazionale” con la capacità di distribuire passaporti virtuali a chi lo desideri. Nelle sale della sede espositiva di Ca’ Tron hanno concepito una mostra distinta in due parti: An apology , un’apologia del momento storico che mette in relazione eventi del passato e possibilità del futuro; il secondo spazio, New Symbolic Disorder con le risposte di cento persone invitate dai delegati NSK a rispondere a un questionario relativo a problematiche individuali e collettive legate, alle prospettive sull’Europa.
La kermesse lagunare è un pianeta multiforme attorno a cui ruotano tantissimi satelliti in vari luoghi della città, che brulica di motivi, proposte artistiche, qualche volta di banalità; tante e tali sono le mostre collaterali che meritano una citazione non solo quelle che sono legate alla Biennale, ma anche quelle che sono state realizzate in concomitanza. La carrellata non può che cominciare da Palazzo Grassi e da Punta della Dogana, dove il discusso Damien Hirst, in mostra fino al 3 dicembre, espone le sue opere inserite in un concetto di tesoro ritrovato (Treasures from the Wrek of the Unbelievable), sculture monumentali, dentro scenografie hollywooodiane, e cimeli diversi, monili e pietre preziose in uno sfoggio di lusso e ricchezza che contrasta fortissimamente con l’epoca attuale. Forse il tempo impiegato in fila potrebbe essere utilizzato per visitare alla Guggenheim la retrospettiva di Mark Tobey (1890-1976), americano che nel campo dell’astrattismo ha un suo ruolo di preminenza, in virtù di un’opera che brilla per disciplina compositiva e forza espressiva, dentro la seduzione per l’oriente a cui fu molto legato. Alla Fondazione Cini, nell’isola di San Giorgio, Luca Massimo Barbero cura la mostra Minimum/Maximum interamente dedicata ad Alighiero Boetti con un confronto affascinante tra le opere di piccola e di grande dimensione; e poi una rassegna dedicata a Robert Rauschenberg (1925-2008), esponente americano del New Dada che nel 1964 vinse il premio per il miglior artista straniero alla Biennale di Venezia.
Il Museo Correr si trasforma emblematicamente nella “Casa dei miei occhi”, come dice il titolo della mostra dell’iraniana Shirin Neshat: 55 ritratti fotografici di persone dell’Azerbaijan appartenenti a religioni diverse.